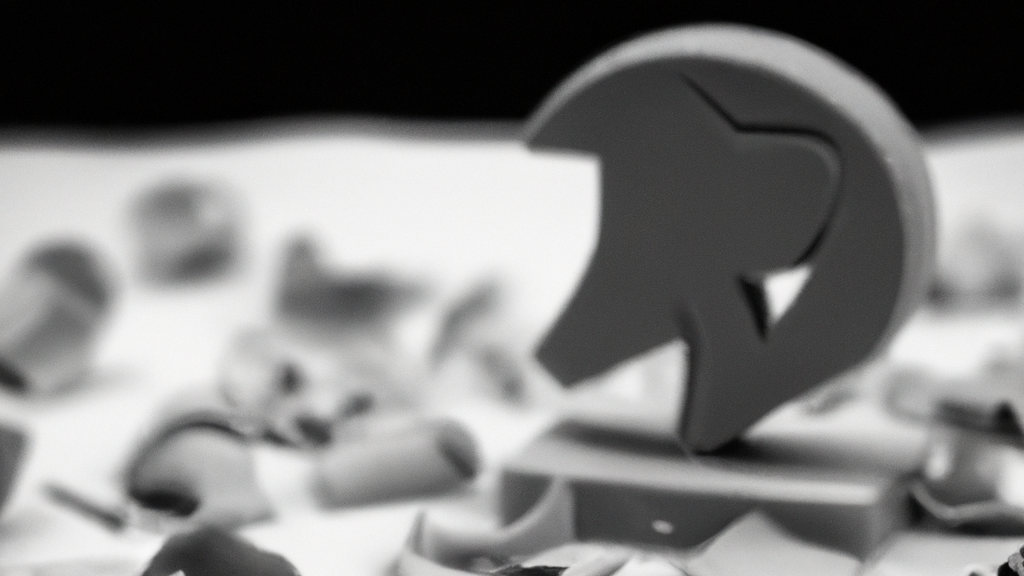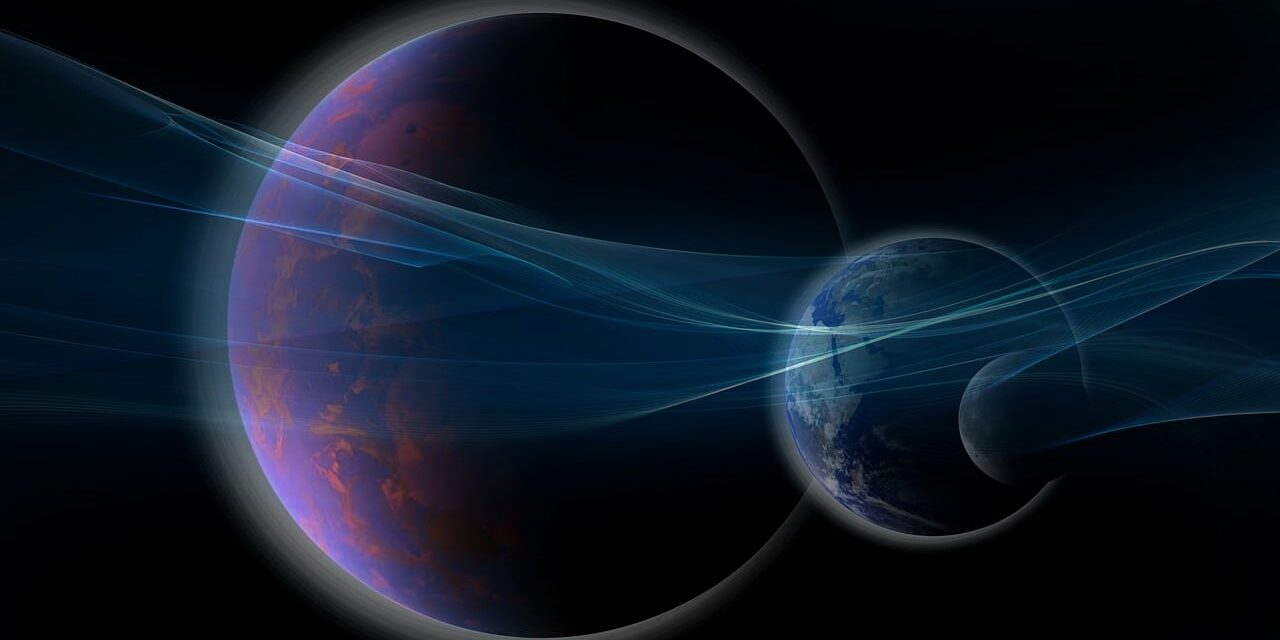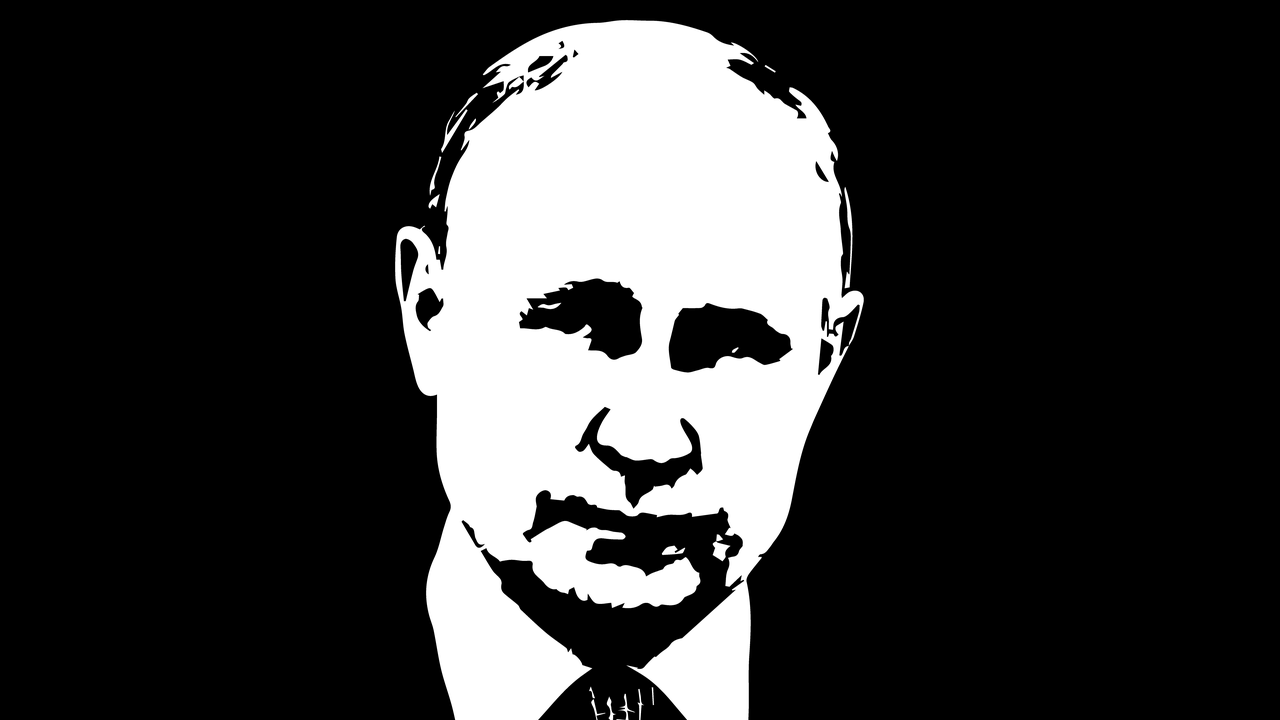Una volta uno disse: il mondo appartiene ai pazzi e il gioco consiste nel lasciarli dormire. Sembra che, però, ormai, a questo gioco, si sia già perso.
È lunedì sera, il 2 novembre 2020. Intorno alle ore 20 di lunedì, vicino alla sinagoga di Stadttempel, in quel momento chiusa, un uomo inizia a sparare contro i passanti. Si tratta delle ultime ore prima dell’inizio del nuovo lockdown per il Covid-19 e le strade del centro città sono ancora molto trafficate. L’attentatore si sposta poi in almeno sei zone diverse del centro, prima che la polizia riesca a neutralizzare l’assalitore alle 20:09 davanti alla chiesa di San Ruprecht.
Quattro sono le persone rimaste uccise e ventidue sono coloro che sono rimasti feriti, sei sono in condizioni gravi. Il centro di Vienna è stato riaperto parzialmente solo molte ore dopo l’attentato, quando la polizia ha permesso alle persone rimaste bloccate nei locali di ritornare a casa attraverso dei corridoi di sicurezza allestiti per l’occasione.
Nel pomeriggio del martedì seguente l’Isis ha rivendicato l’attentato: Vienna rimane in stato di massima allerta. Continuano le perquisizioni in diverse case ai cittadini è consigliato restare in casa, o, perlomeno, ad evitare il centro della città. Le scuole sono state chiuse e la comunità ebraica ha deciso la serrata di tutte le sue istituzioni e istituti.
Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, rivolgendosi alla nazione ha detto:” […] Noi dobbiamo essere coscienti che non c’è una battaglia fra cristiani e musulmani, o fra Austria e i migranti. No. Questa è una lotta fra le molte persone che credono nella pace e alcuni che auspicano la guerra. È una lotta fra civiltà e barbarie; e questa lotta l’affronteremo con ogni determinazione.”.
L’attentato di Vienna è un evento che nella sua tragicità risveglia in un periodo in cui l’emergenza sanitaria del covid-19 sta saturando ogni considerazione sulla situazione storica in cui si trova.
Benché la percezione sia diversa ormai, le parole del cancelliere Kurz mettono un punto sulla questione che, nonostante la crisi sanitaria immane che si sta vivendo, il contrasto e la tensione conseguenti tra le diverse realtà geopolitiche e culturali del globo permane: non si ferma, anzi prosegue nel suo corso.
È tragico osservare come le vittime principali della pandemia sono l’economia intesa nell’etimologia greca di “legge della casa”, la percezione contestualizzata del periodo storico che si vive e, soprattutto, la fiducia.
Non c’è più fiducia nel prossimo, nella comunità, negli scienziati, nel governo, nel futuro, in generale nell’uomo. Il monopolio mediatico del covid-19, coadiuvato dalla sua gestione non esente da critiche, ha portato l’uomo a perdere contatto con se stesso e soprattutto con la situazione che comunque si vive.
Una società può decidere di fermarsi: la storia, intesa come insieme di tutte le realtà umane che si evolvono nel tempo e interagiscono, no.
Rimane la considerazione che il primo intervento efficace contro l’epidemia sarebbe iniziare a ricostruire un minimo di fiducia, in quanto sarebbe la base per rifondare quella coscienza di cui accenna il cancelliere austriaco Kurtz, nella speranza che non sia necessaria un’altra tragicità del genere per riportarci nuovamente alla consapevolezza del mondo in cui viviamo.